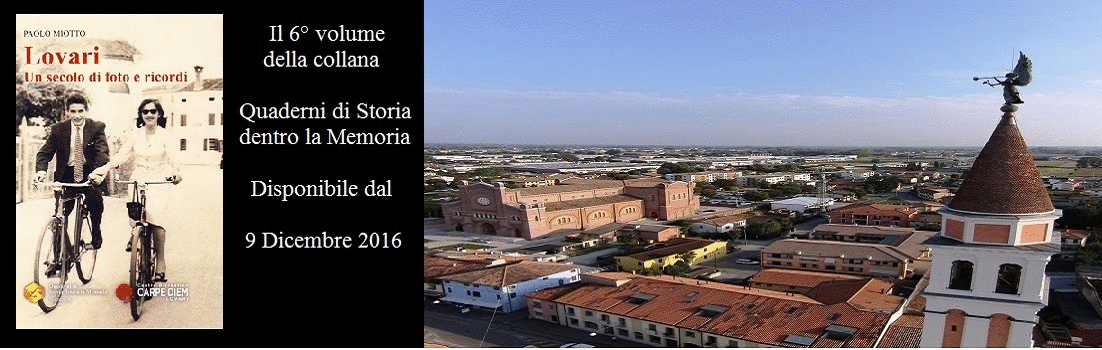Durante la Grande Guerra (1915-1918) che non risparmiò Treviso e la sua diocesi, un personaggio di curia scrisse un diario bellico a scopo storico-memorialistico rimasto in parte inesplorato. L’autore è Mons. Luigi Giacomo Zangrando (1868-1936), allora vice cancelliere della curia vescovile, maestro di camera e segretario del vescovo Longhin. Personaggio di rilievo della curia trevigiana e appassionato cultore di storia e archivistica, Zangrando è ben cosciente di assistere a un periodo storico particolare e tragico nel quale la chiesa non è rimasta a guardare. Per questo motivo decide di annotare ogni giorno l’evolversi del conflitto bellico e nel frattempo di raccogliere tutta la documentazione della quale viene in possesso e che testimonia l’azione del Longhin e del clero diocesano.
L’obiettivo dichiarato dello scritto è quindi raccogliere per la storia l’opera e lo spirito che animarono il vescovo e le relazioni che questi ebbe con la popolazione, il clero, le autorità civili e militari. Accompagnando spesso il vescovo, venendo personalmente a contatto con gli interlocutori del Longhin, ricevendo corrispondenza dai parroci e incontrando ogni giorno i canonici del capitolo, Zangrando si trova in una posizione privilegiata che gli permette di raccogliere informazioni di prima mano. Il diarista sente la responsabilità di dimostrare con documenti e testimonianze che il Longhin, a differenza delle autorità civili, anche nel momento più tragico della rotta di Caporetto (24 Ottobre 1917) non abbandonò la diocesi e volle che il suo clero facesse altrettanto, rimanendo accanto alla popolazione. Per dare fondamento all’intrepida azione del vescovo, nel prologo Zangrando scrive: In Nomine Domini Amen. Ab Incarnatione Dei et Domini Nostri Iesu Christo anno 1915. Notizie sulla guerra cominciata il 24 Maggio 1915 a mezza notte, finita sulle rive della Piave, come quella del 1813, sulla fine d’ottobre 1918. A questo promemoria [il diario] vanno unite 23 buste con carteggi indicati all’esterno.
Non mancavano, infatti, i detrattori che per tutto il conflitto accusarono il Longhin e una parte dei parroci di essere austriacanti e disfattisti perché aderenti al programma di pace promosso da papa Benedetto XV, che aveva definito profeticamente la guerra una inutile strage. In realtà il Longhin è consapevole che nell’ora della prova il mondo cattolico non può e non deve sottrarsi all’impegno diretto per accelerare la fine della guerra. Per questo motivo nel 1918 scrive ai parroci accusati di disfattismo: la vostra innocenza è provata; i tribunali stessi vi hanno reso ragione. Si vergognino i vostri accusatori per i quali, nell’ora del supremo dolore della patria, più del dovere, della concordia, valse il livore, né parve cosa indegna la calunnia subdola e la delazione segreta.
Nello stesso tempo Longhin non dimentica i soldati sopravvissuti all’orrore, fra i quali si trovavano a rivestire la divisa anche tanti chierici, suddiaconi, diaconi e sacerdoti trasferiti effettivi alle compagnie di Sanità del proprio Corpo d’Armata. Nell’ottobre del 1918, a guerra appena conclusa, scrive al clero: I soldati sono fratelli, figli della nostra Italia, figli del popolo cristiano, figli pure della Santa Madre Chiesa […] Sono essi che portano il più grave peso della guerra, essi che hanno pagato per la patria il tributo del sangue. Nel maggio 1916, nel novembre 1917, nel giugno di quest’anno essi hanno difeso eroicamente le nostre terre e le hanno salvate dall’occupazione nemica […] Il soldato italiano non ha che i titoli della nostra riconoscenza. Facciamogli pertanto onore perché se lo merita […] né mai esca dalle nostre labbra espressione alcuna che induca a debolezza o a viltà: lodiamone piuttosto l’amore per la patria e il coraggio. Ogni giorno il vescovo si prodiga per sostenere le iniziative a favore dei soldati e delle famiglie che hanno i loro figli e mariti al fronte. Fa stampare un vademecum per i cappellani militari e un opuscolo per i soldati dal titolo Salute e gloria al Soldato Italiano che è dispensato in migliaia di copie. Mobilità l’Azione Cattolica perché non si sottragga all’impegno patriottico e cittadino degli iscritti, ogni sera celebra particolari offici in cattedrale per i militari. Quasi ogni pomeriggio si reca nell’ospedale militare allestito in seminario a incontrare i feriti del fronte carsico. Zangrando assiste a questi incontri e trascrive alcuni dialoghi nei quali i convalescenti raccontano al Longhin le loro disavventure: Una palla mi entrò dalla bocca, mi asportò i mascellari. Una palla filante mi asportò metà avambraccio. Un proiettile mi spaccò l’occhio sinistro. Lo stesso avviene nelle corsie dell’ospedale civile, dove sono ricoverati gli ufficiali e altri soldati. Per tutti una parola di vicinanza, l’accoglimento di preghiere e confidenze, tanto che il prefetto e il comandante di presidio propongono al governo un riconoscimento al Longhin e al seminario.
Tramite il cappellano militare romano Giuseppe Rinaldi, incaricato dal ministro della guerra di intrattenere rapporti con i cappellani militari sparsi sui fronti, il vescovo riesce a far spedire gli altarini da campo e far giungere ai soldati 10.000 rosari e altrettanti crocifissi, 60.000 medaglie e 70.000 copie dell’opuscolo sopra accennato. Grazie ai parroci più intraprendenti, come Mons. Vitale Gallina a S. Zenone degli Ezzelini, veniamo a sapere da Zangrando che il Longhin aveva promosso la cooperazione fra famiglie contadine, anche di parrocchie diverse, per lavorare i campi durante le festività. Nel frattempo i si dice, mi pare, ho sentito, non cessano. La Treviso bene nonostante il momento storico critico trova il tempo di sparlare contro il mondo cattolico. L’accusa di disfattismo ritorna con frequenza nel diario di Zangrando e il vescovo non cessa di inviare consigli al clero perché nella predicazione si usi prudenza, evitando apprezzamenti che potrebbero essere male interpretati da chi ha tutto l’interesse di gettare il discredito sul ceto sacerdotale. L’avvocato Giuseppe Benvenuti raccoglie alcune malevolenze e le invia al vescovo che, per tutta risposta, ribatte con un memoriale nel quale in dodici articoli difende il proprio operato e quello dei sacerdoti. I fatti, nascosti e pubblici che siano, gli danno ragione. A seguito delle incursioni aeree nemiche, che dal 18 aprile al 16 luglio 1916 bombardano pesantemente la città, il 27 aprile 1917 Longhin esprime in cattedrale il voto solenne di erigere una chiesa a Maria Ausiliatrice fra S. Antonino e S. Lazzaro. In diocesi è un pullulare di iniziative cattoliche private e pubbliche: nel mese di maggio il vescovo predica a i soldati e invoca la protezione della Madonna, istituisce un segretariato per la consacrazione della famiglie al Cuore di Gesù, collabora con la deputazione provinciale per la promozione del comitato di assistenza economica e morale dei soldati invalidi e degli orfani, intrattiene un importante carteggio con i generali Diaz e Scipione.
Si giunge al momento più critico: la dodicesima battaglia dell’Isonzo (24 ottobre-8 novembre 1917), meglio nota come la disfatta di Caporetto. In poche ore è il caos. La XIV armata austro-tedesca sfonda in tre punti il XXVII Corpo d’armata costringendo soldati e civili a ripiegare di qua del Piave. A Treviso le autorità civili si trasferiscono oltre il Po mentre le truppe nemiche entrano in diocesi di Treviso fino a Noventa e S. Donà. Il vescovo allontana oltre il Po gli istituti religiosi femminili, degenti e personale dell’ospedale civile convergono a Villa Raverio in Lombardia. Partono per la Biblioteca Vaticana anche i preziosi, le opere d’arte e i documenti storici della diocesi. E i preti? Che destino è loro riservato? Longhin non ha dubbi: devono stare al proprio posto, in mezzo ai cari figli, per essere d’aiuto e di conforto ai tanti poveretti che ora più che mai sentono urgente la necessità di essere sorretti dal pastore. Il vescovo munito di salvacondotto inizia a girare con un’auto per i vari fronti e concede pieno potere ad alcuni sacerdoti fermi nelle undici parrocchie occupate dallo straniero e nelle cinquanta sgomberate perché prossime alla linea di guerra. L’anno si trascina fra fame, sfollati e notizie incerte.
Il 1918 si apre con nuovi rai aerei su Treviso. Il Longhin concede l’Istituto Turazza come lazzaretto e raccoglie fondi per gli sfollati ma i delatori e calunniatori continuano la loro opera facendo arrestare e internare per disfattismo i parroci di Cendon, S. Liberale di Castelfranco, Paese e del vicariato di Sant’Elena. Un fitto carteggio fra il vescovo e le autorità competenti testimonia l’opera messa in campo per ottenere la liberazione dei sacerdoti. La stampa italiana lo definisce ormai il Vescovo del Montello e del Piave. Rimane fino all’ultimo, nonostante gli inviti del vescovo Ridolfi di Padova ad andarsene dalla città, fino alla vittoria delle truppe italiane del novembre 1918. La guerra è finita, ma la diocesi è in uno stato di desolazione devastante. E’ tutto da ricostruire, materialmente e moralmente, e il Longhin non si tira indietro nemmeno in quest’occasione.
Raccoglie il clero e la popolazione indicando la via da seguire soprattutto nelle parrocchie della sinistra Piave, ridotte al nulla dai bombardamenti di entrambi i fronti. Grazie al diario di Zangrando e alla documentazione che ha saputo raccogliere e tramandare, è possibile ripercorrere il quadriennio della Grande Guerra così come lo vide il beato Longhin, rendendo giustizia di quel disfattismo del quale pure lui fu accusato.